

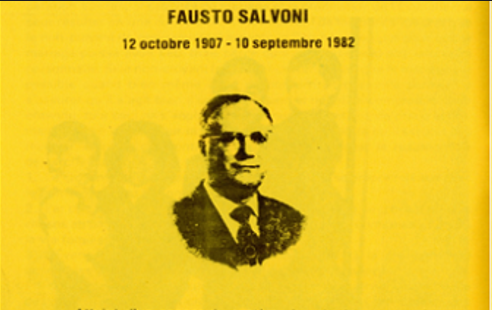
Tra i fogli e gli appunti di Fausto Salvoni (1907-1982) abbiamo ritrovato un suo vecchio studio del 1935, scritto quando ancora era sacerdote cattolico e quando scriveva per La Scuola Cattolica e l'Enciclopedia Cattolica. Lo studio tratta della storiografia ebraica, il titolo è: “La storiografia degli antichi israeliti”. Un testo inedito nelle nostre chiese. Un testo che va ad arricchire la bibliografia dei manuali di storiografia del mondo antico. Esistono diversi manuali in italiano sulla storiografia greca e sulla storiografia romana, ma pochi sulla storiografia ebraica. Per questo motivo sul sito (nella rubrica Appunti e Letture) stiamo pubblicando le varie parti del manoscritto di Salvoni sulla storiografia israelitica, trascritte e corrette, senza però le note a piè di pagina, per rendere il testo più accessibile e leggibile a tutti. Con la preghiera che questo testo possa essere utile alle comunità e che ogni nostro sforzo possa dare a Dio la gloria.
In questa terza parte, intitolata “La scienza storiografica: 1) Le fonti.” (seguirà la quarta parte sul valore delle fonti), Salvoni riporta le fonti della storiografia, corredate da un gran numero di citazioni di testi biblici dell’Antico Testamento. Il nome dei libri biblici citati segue la versione dei Settanta e della Vulgata, e non sempre corrisponde con i nomi che oggi noi diamo ai libri biblici, così, per esempio, “Paralipomeni” corrisponde al libro delle Cronache e “3 Re” al nostro 1 Re. Le fonti elencate sono quattro: fonti auliche; fonti sacerdotali; fonti profetiche; fonti orali. La sua ricerca delle fonti si basa esclusivamente sul testo biblico. In una nota egli accenna agli studi storico-critici sulla formazione della Bibbia che in quegli anni (il testo di Salvoni porta la data del mese di aprile 1935) cominciavano a diffondersi anche in Italia: “Non è ora il caso di provare la possibilità di tale trasmissione con esempi tolti da poemi omerici, finlandesi o arabici; già sopra l'argomento fu scritto molto da vari autori, talvolta anche esageratamente.” Nelle parole di Salvoni possiamo anche cogliere la spiegazione che veniva data in ambito storico-critico sulle tradizioni orali, la loro trasmissione e la formazione dei libri della Bibbia: è la stessa spiegazione che viene data per i poemi omerici e per tutti i racconti epici antichi. Salvoni: “Queste tradizioni mnemoniche sempre accompagnano la vita del popolo israelitico e ne costituiscono una fonte primaria, esse precipuamente si riferiscono alla storia delle origini e a quelle patriarcali in cui lunghi documenti dovevano necessariamente far difetto.” Noi invece crediamo che la formazione della Bibbia non dipenda dal bisogno di un popolo di dare forma scritta alle proprie tradizioni, bensì dalla volontà di Dio di far scrivere in un libro la storia della salvezza.
La scienza storiografica: 1) Le fonti. Leggendo la Bibbia è doveroso notare la cura scrupolosa con cui libri attualmente smarriti, vengono citati quasi ad avvalorare o completare le proprie narrazioni. Gli autori di Samuele e dei Re spesso si richiamano ad annali intitolati dibre hajjamim, Vulgata, Verba dierum, cioè atti, fatti, annali dei re di Israele o di Giuda (3 Re 11, 41 - annali di Salomone - ; 3 Re 14, 19. 29; 15, 7. 23, 31; 16, 6. 14. 20. 27; 22, 39. 46; 4 Re 1, 18; 8, 23; 10, 34; 12, 19: 13, 8. 12; 14, 15. 18. 28; 15, 6. 11. 15. 21. 26. 31. 36; 16, 19; 20, 20; 21, 17. 25; 23, 28; 24, 5; 2 Esdra 12, 23. La parola dabar, plurale debarim, significa parola e spesso, come nei passi citati, atti, fatti, avvenimenti.
L'autore dei Paralipomeni o libro delle Cronache cita spesso annali regi da lui chiamati: sefer ha-melakim, Vulgata, liber regum, che però con probabilità non sono diversi dai sopracitati giornali dell'autore dei Re (1 Paralipomeni 9, 1; 2 Par. 16, 11; 20, 34; 24, 27; 25, 26, 27, 7: 28, 26; 32, 32: 33, 18; 35, 27; 36, 8). Tra le varie fonti, in due passi delle cronache troviamo per la prima volta menzione di un “Midras ha-nabi Iddo” o Midras del profeta Iddo (Addo), e di un “Midras sefer ha-Melakim” o Midras del libro dei Re (2 Paralipomeni 13, 22 e 24, 27). È molto difficile congetturarne il loro contenuto: basandoci sul significato che assumerà posteriormente il vocabolo Midras potremmo pensare a una amplificazione operata sul libro dei Re e sopra l’opera di Iddo. Tuttavia preferibilmente possiamo interpretare il termine Midras nel valore di “libro” e di conseguenza eliminare con i LXX il termine esplicativo sefer in 2 Paralipomeni 24, 27. Parte di queste memorie annalistiche devono essere opera di storiografi ufficiali, istituiti da Davide, quando pensò di organizzare la corte secondo i modelli orientali.
Un’altra notevole parte espressamente viene attribuita a cronisti volontari, generalmente dei profeti. Samuele, Natan e Gad scrissero almeno parzialmente la storia di Davide (1 Paralipomeni 29, 29), Natan, Ahias silonita e Addo il Veggente quella di Salomone (2 Paralipomeni 9, 29), Semaia e Addo parlarono di Roboam (ib. 12, 15), mentre Addo trattò di Abia (13, 22). La vita di Ozia ed Ezechia risale a Isaia figlio d'Amos (26, 22; 32, 32); mentre quella di Giosafat e Manasse sono rispettivamente opera di Jehu ben Hanani (20, 34) e di un certo Hozai (33, 19).
Presso i popoli semiti, ciò che interessa non è tanto il nome di chi narra un evento, bensì il dato tramandato. In genere quindi presso gli ebrei e non ebrei le opere storiche son tutte anonime, a eccezione di questi brani, vera novità nel campo semita. Sembra che il relatore quasi ad avvalorare il suo dato storico si compiaccia di nominare questi autori che al pari di lui trattarono l'argomento, e che, come profeti, dovevano godere indiscussa autorità presso gli Israeliti (l'ignoto compilatore di 2 Maccabei premurosamente ci assicura d'aver compendiato la sua opera storica in cinque volumi di Giasone cireneo; 2 Maccabei 2,24).
Per l'epoca davidica e predavidica due altri libri sono menzionati: il libro delle guerre di Jahveh, “Sefer milhamot Jahveh” (Numeri 21, 14) e “Sepher ha-jasar”, libro del prode (?), Giosuè 10, 13; 2 Samuele 1, 18 (da alcuni con 3 Re 8,53 LXX corretto in sepher ha-sir “Libro del canto”) probabilmente raccolta di canti epinici o nazionali jahvistici d'epoca molto arcaica. Forse a queste collezioni risalgono i carmi di Balaam, documenti letterari di primo ordine (Numeri 23-24); il cantico di Mosè dopo il passaggio del Mar Rosso (Esodo 15, 1-19), quello di Debora (Giudici 5, 2-31); certamente il carme trionfale di Gabaon (Giosuè 10, 12-14) e l'elegia davidica su Gionata (2 Samuele 1, 18).
Ma anche se tali documenti non vengono citati, spesso ci è permesso intravvedere almeno nelle linee fondamentali le varie fonti usate e che ben si potrebbero raggruppare in:
a) Fonti auliche: questo tipo di fonti o derivazioni ci appaiono per un grande interesse verso la dinastia regnante, di cui enumerano principi (2 Samuele 3.2-5; 5, 14-16) e ufficiali (8, 16-18; 20, 23-26), elencano vittorie in forma breve e riassuntiva molto simile alle corrispondenti narrazioni assiro babilonesi (8,1-15; 21, 16-22; 23, 8-39).
b) Fonti sacerdotali: facilmente riconoscibili al loro interesse per il culto, il tempio, la legge di Iahve, e per quanto i sacerdoti stessi hanno operato. La costruzione del tempio sotto Salomone (3 Re 6, 1-7, 50), la reazione rivoluzionaria contro Athalia preparata segretamente dai sacerdoti (4 Re 11, 1-20); l'erezione d'una cassa a beneficio del tempio sotto Joas (12, 1-16); l'intrusione di un nuovo altare sotto Achaz (16, 10-18); la consegna a Sennacherib dell'oro sacro per la liberazione di Gerusalemme (18, 14-16) (Contro lo Schmidt, credo che la derivazione templare si inizi non nel v. 13 ma bensì nel 14, poiché da questo punto sino al v. 16 la diversità della fonte si manifesta dallo stesso nome di Ezechia che ivi per ben cinque volte ha la forma breve Hizqijjah, contro la forma lunga che altrove si presenta circa 29 volte, Hizqijjahu); la riforma cultuale del re Giosia (22, 3-23, 27) sembrano bene derivare dalla sfera sacerdotale che le conservò in archivi templari. Negli stessi archivi potevano esser racchiuse le relazioni sopra l'attività di Esdra, al pari delle preziose memorie autobiografiche di Neemia, utilizzate dal cronista nell'ultima parte del suo volume.
c) Fonti profetiche: il centro d'attrazione si sposta verso i profeti. Anche se in taluni punti tale origine rimane incerta - sono dubbi gli episodi di Natan (2 Samuele 7, 1-29; 12, 1-15); di Gad (2 Samuele 24, 11-14); di Ahia silonita (3 Re 11, 29-39) -, per altri non possiamo punto dubitarne; chi non la riconosce negli episodi d'Elia ed Eliseo (3 Re 17- 4 Re 13 passim), così diversi, anche stilisticamente, dalle rimanenti narrazioni bibliche?
d) Fonti orali: relazioni cioè tanto famigliari che nazionali trasmesse a memoria di generazione in generazione. Non è ora il caso di provare la possibilità di tale trasmissione con esempi; già sopra l'argomento fu scritto molto, talvolta anche esageratamente, da vari autori ai quali mi permetto rimandare per ulteriori notizie. Queste tradizioni mnemoniche accompagnano la vita del popolo israelitico. Tale trasmissione orale ci spiega sia l’affinità con tradizioni d'altri popoli semiti sia lo stato nebuloso e incerto (e leggendario) che troviamo nelle tradizioni degli altri popoli.